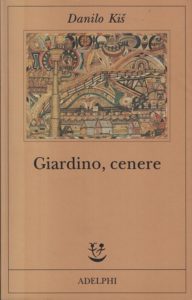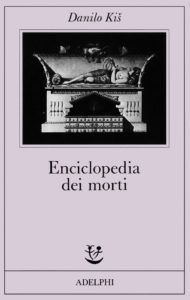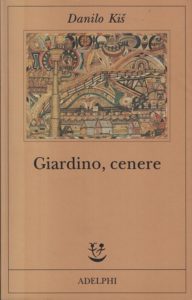
Profumo di vaniglia e semi di papavero, un vassoio nichelato con sottili mezzelune lasciate dal fondo dei bicchieri, piccoli tram azzurri, gialli e verdi che si rincorrono tintinnando, il cancello di un parco dietro il quale spuntano cervi e cerve, «come ragazzini di buona famiglia di ritorno dalla lezione di piano». All’inizio di questo romanzo c’è un pullulare di sensazioni, una nube tattile, olfattiva, onirica, che si sposta in una cauta esplorazione del mondo, come l’occhio del bambino Andreas, il narratore. La parola «morte» trafigge questa nube, è un numero fatale stampato sul buio. E il bambino gioca con il sonno, gli tende agguati, in preparazione alla grande lotta con la morte. Aveva deciso di «assistere un giorno consapevolmente alla venuta della morte e così vincerla», e nell’attesa voleva sorprendere l’angelo del sonno.
Intorno ad Andreas, vediamo la sorella Anna, che piange la sera perché il giorno è finito e non torna più; e la madre Marija, seduta davanti a una imponente macchina da cucire Singer di ghisa nera. E soprattutto vediamo, seppure soltanto in apparizioni imprevedibili e balzane, il padre Eduard Sam, ispettore delle ferrovie a riposo, ma in realtà trickster decaduto, che non dispone più di molti poteri, eppure è ancora aureolato di eventi prodigiosi e irrisori. Autore di un Orario delle comunicazioni tranviarie, navali, ferroviarie e aeree che, arricchendosi di edizione in edizione, si trasforma in opera interminabile, come una mappa che volesse coincidere con il territorio rappresentato, Eduard usa mostrarsi con bombetta e redingote imbrattata, e sfida l’iniquità del mondo dietro occhiali con montatura metallica, stringendo in pugno un bastone. Compreso della sua vocazione di mistificatore, non è mai se stesso, ma il nebbioso ricordo di qualcos’altro, e il giovane Andreas, fantasticatore selvaggio, percepisce in lui la compresenza di molte vite: «Ed eccolo, mio padre, seduto nel carro accanto a una giovane zingara dalle poppe rigonfie, maestoso come il principe di Galles o, se volete, come un croupier o come un maître d’hôtel (come un illusionista, come un impresario di circo, come un domatore di leoni, come una spia, come un antropologo, come un maggiordomo, come un contrabbandiere, come un missionario quacchero, come un sovrano che viaggi in incognito, come un ispettore scolastico, come un medico di campagna e, infine, come un commesso viaggiatore, rappresentante di una compagnia occidentale per la vendita dei rasoi di sicurezza)». Un giorno, in un raro momento di sobrietà, Eduard accenna al figlio il suo segreto: «Non è possibile, giovanotto mio, e questo ricordatelo per sempre, non è possibile recitare la parte della vittima per tutta la vita senza diventarlo alla fine davvero». La storia si incaricherà presto di avverare la profezia.
In una continua osmosi di sensazione e visione, questo romanzo raggiunge una precisione evocativa che penetra nelle fibre della mente, in un modo che ricorda Bruno Schulz. Qui, come una splendida carovana di stracci e paccottiglia, ci sfila davanti il mondo saturo di esperienze dell’Europa centrale mentre sta per abbandonarsi alla morte, visto con gli occhi del bambino sognatore e ribelle che alla morte voleva dare scacco.