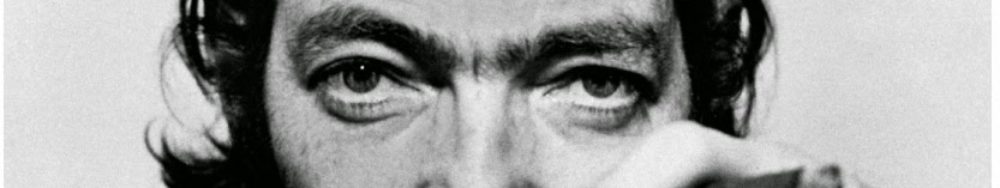In tempi di insistita esaltazione delle virtu «spontanee» del mercato e di reiterate esortazioni a liberare lo sviluppo delle società capitalistiche da ogni forma di «vincolo» che ne impedisca la piena espansione, può forse sembrare estraneo allo spirito dell’epoca, o persino stravagante, sostenere che il capitalismo è un sistema storico, e cioè dotato, come tutti gli oggetti storici, di un percorso nel tempo e nello spazio, di una vita che lo ha portato a nascere, svilupparsi e modificarsi, e che lo porterà verosimilmente — in una qualche forma, in un qualche momento — anche a morire, cioè ad essere sostituito da qualcos’altro che lo seguirà. Questo di Immanuel Wallerstein è davvero un libro controcorrente, e non soltanto perché unisce in modo esplicito e senza infingimenti l’analisi dello storico a una forte tensione morale. L’autore ripercorre la storia di questo universo spazio-temporale, di questo «sistema-mondo» che è stato ed è il capitalismo, considerando anche le ingenuità e gli errori di coloro che hanno cercato di analizzare il sistema con atteggiamento critico. Ai caratteri distintivi di questa economia-mondo, che ne hanno segnato la lunga storia, dal secolo XVI fino a oggi — la mercificazione generalizzata, la crescente ma non univoca proletarizzazione del lavoro, la sempre maggiore unificazione dei mercati, la costituzione di una rigorosa gerarchia degli spazi economici — si accompagnano i tratti politiche ideologici del sistema: l’articolazione delle etnie, delle nazionalità e degli stati; la dinamica delle lotte politiche e sociali, a base classista o infra-capitalistica; la nascita e lo sviluppo dei movimenti antisistemici, nella duplice versione socialista e nazionalistica; la crescita e la funzione dei grandi aggregati di sostegno ideologico, dal zismo, all’universalismo, al mito del progresso. Sostenuto da un vastissimo retroterra di conoscenze analitiche, l’autore va accumulando nei suoi lavori sul Sistema mondiale della economia moderna, il ragionamento è qui sviluppato su un registro di estrema sintesi. Lo stesso linguaggio, di una densità voluta e ricercata testimonia lo sforzo di abbracciare con un unico sguardo una realtà storica così multiforme e complessa.
In tempi di insistita esaltazione delle virtu «spontanee» del mercato e di reiterate esortazioni a liberare lo sviluppo delle società capitalistiche da ogni forma di «vincolo» che ne impedisca la piena espansione, può forse sembrare estraneo allo spirito dell’epoca, o persino stravagante, sostenere che il capitalismo è un sistema storico, e cioè dotato, come tutti gli oggetti storici, di un percorso nel tempo e nello spazio, di una vita che lo ha portato a nascere, svilupparsi e modificarsi, e che lo porterà verosimilmente — in una qualche forma, in un qualche momento — anche a morire, cioè ad essere sostituito da qualcos’altro che lo seguirà. Questo di Immanuel Wallerstein è davvero un libro controcorrente, e non soltanto perché unisce in modo esplicito e senza infingimenti l’analisi dello storico a una forte tensione morale. L’autore ripercorre la storia di questo universo spazio-temporale, di questo «sistema-mondo» che è stato ed è il capitalismo, considerando anche le ingenuità e gli errori di coloro che hanno cercato di analizzare il sistema con atteggiamento critico. Ai caratteri distintivi di questa economia-mondo, che ne hanno segnato la lunga storia, dal secolo XVI fino a oggi — la mercificazione generalizzata, la crescente ma non univoca proletarizzazione del lavoro, la sempre maggiore unificazione dei mercati, la costituzione di una rigorosa gerarchia degli spazi economici — si accompagnano i tratti politiche ideologici del sistema: l’articolazione delle etnie, delle nazionalità e degli stati; la dinamica delle lotte politiche e sociali, a base classista o infra-capitalistica; la nascita e lo sviluppo dei movimenti antisistemici, nella duplice versione socialista e nazionalistica; la crescita e la funzione dei grandi aggregati di sostegno ideologico, dal zismo, all’universalismo, al mito del progresso. Sostenuto da un vastissimo retroterra di conoscenze analitiche, l’autore va accumulando nei suoi lavori sul Sistema mondiale della economia moderna, il ragionamento è qui sviluppato su un registro di estrema sintesi. Lo stesso linguaggio, di una densità voluta e ricercata testimonia lo sforzo di abbracciare con un unico sguardo una realtà storica così multiforme e complessa.