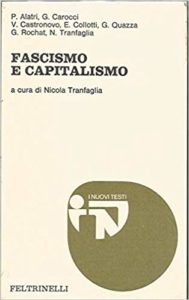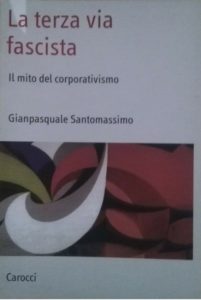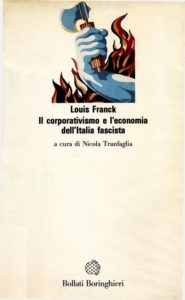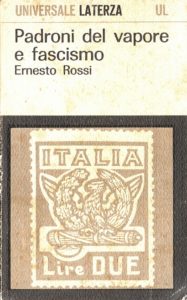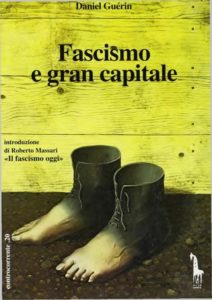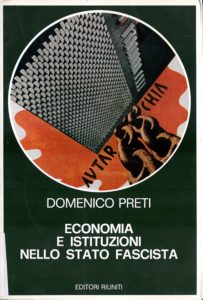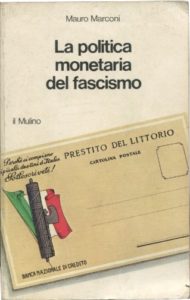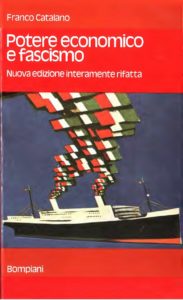
Il capitalismo italiano alla fine della prima guerra mondiale; la spedizione di Fiume; l’occupazione delle fabbriche; da Giolitti al Congresso di Livorno; l’offensiva degli agricoltori contro i contadini; le conseguenze politiche ed economiche della disoccupazione; la lotta contro i provvedimenti tributari da parte della borghesia: ecco i capitoli principali di questo grande libro sulla crisi del dopoguerra 1919-1921.
“In effetti,” scrive Franco Catalano, “leggendo queste pagine, forse si rimarrà meravigliati nel vedere come l’atteggiamento delle classi sociali si sia ripresentato, in anni a noi vicinissimi, quale era stato fra il 1919 e il ’21: gli stessi fenomeni che si sono potuti notare molto di recente si erano notati già allora.” E aggiunge: “Si è sempre parlato, ad esempio, di debolezza della classe dirigente liberale di fronte al fascismo, ma raramente si è specificato meglio in che cosa tale debolezza sia consistita.” E in realtà questo libro, che è del 1964 e che ora è stato interamente rifatto, risponde a questo duplice obiettivo: da una parte la ricostruzione di uno dei periodi decisivi della nostra storia recente attraverso l’analisi della situazione economico-sociale in cui il fascismo è sorto, delle complicità e delle ragioni che l’hanno condotto al potere; dall’altra, il continuo riporto ai problemi contemporanei, la ricerca e la messa in luce di analogie, spesso formidabiIi, con le vicende che stiamo quotidianamente vivendo (inflazione, disoccupazione, tasse, crisi dell’agricoltura ecc.).
Ne viene fuori un libro magistrale, in cui la raccolta di dati e notizie rari o inediti si salda con una “visione”, che è scientifica e militante, in cui tutta una certa realtà è presente con la sua concretezza e coi suoi significati; e in cui sembra davvero realizzarsi la convinzione che “la storia deve soprattutto preoccuparsi di mostrare come si sono svolti gli avvenimenti, di chiarirne le cause interne e, perciò, di far vedere perché mai la vita degli uomini ha preso, in quel determinato periodo, un orientamento piuttosto che un altro”